
LA STORIA DEL SAMARITANO E DEI VIANDANTI INDIFFERENTI
11 marzo 2022
Contributo alla riflessione sul tema “La storia del samaritano e dei viandanti indifferenti”. Di Giovanni Lamagna
La prima riflessione che mi viene da fare dopo aver letto e riletto la parabola (Luca 10, 25-37) nasce da un riferimento ad un altro passo evangelico, laddove Gesù afferma (in Matteo 7, 21): “Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.”
Non sono dunque i sacerdoti e i leviti, che custodiscono il tempio e magari pregano dalla mattina alla sera, ad avere garantito per loro il “regno dei cieli”, ma coloro che fanno (concretamente) la volontà di Dio.
Riflessione che poi mi rimanda immediatamente ad un altro passo evangelico, quello di Matteo 25,31-40: “Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me.”
“Fare la volontà di Dio” è, dunque, vedere Dio nell’affamato in cerca di cibo, nell’assetato in cerca di bere, nel forestiero in cerca di ospitalità, nell’ignudo in cerca di un vestito. Non è altro; è questo il segno, il metro di misura.
In altre parole e in più occasioni, Gesù nel Vangelo è netto: non è l’abito (talare e manco il clergyman) che fa il cristiano, ma sono le sue opere; e in modo particolare l’amore verso il prossimo. Che avvalora e dà fondamento teologico ad una delle “battaglie” che maggiormente caratterizza il pontificato di papa Francesco: quella contro il clericalismo, cioè contro la casta dei preti e dei religiosi, i quali tendono a sentirsi superiori o perfetti solo perché indossano una divisa.
Questo pensiero mi rimanda poi ad una ulteriore riflessione, quella che faceva spesso il cardinale Martini, il quale era solito dire: “Per me la principale distinzione da fare non è tra credenti e non credenti, ma quella tra pensanti e non pensanti”; che è una riflessione di grande apertura ed incoraggiamento verso di noi, comunemente definiti “non credenti”.
E però io, da non credente, pur apprezzando molto questa apertura di Martini, ne vedo un limite. Il cardinale Martini era un grande uomo di pensiero e per lui il pensiero era un grande valore. Come del resto lo è per me. E però per me c’è un valore che supera il pensiero; ed è la coerenza tra il pensare e l’agire.
Che valore ha, infatti, pensare bene e poi agire male?
Tra il pensare bene e l’agire male passa, a me pare, la stessa differenza che c’è tra il “predicare bene e il razzolare male”: il secondo invalida del tutto il primo.
Per cui mi permetterei di correggere (pur con tutto il rispetto, grande, che ho per il cardinale Martini) la sua affermazione: la vera differenza non è quella tra credenti e non credenti, e neanche quella tra pensanti e non pensanti; ma tra coloro che fanno il bene e coloro che fanno il male.
Differenza che mi pare sia implicita nella parabola evangelica “del samaritano e dei viandanti indifferenti”, ne costituisca il senso profondo.
Per cui il problema a questo punto diventa non tanto quello della fede (Dio esiste? Sì, esiste! No, non esiste!), quindi non tanto di natura teoretica, quanto di natura pratica: quello di distinguere il bene dal male.
Che è poi il problema più antico della storia dell’Umanità, quello con cui si dovettero confrontare ben presto, poco dopo la loro creazione da parte di Dio, già Adamo ed Eva, quando furono “tentati” (e meno male!) di mangiare il frutto dell’albero “della conoscenza del bene e del male” (Genesi; 2,9 e 2,16).
Problema per la cui soluzione mi pare abbiamo a disposizione tre strumenti, tre vie, tre metodi.
Il primo è quello di fare ricorso alle convenzioni sociali: è bene quello che dai più è ritenuto e soprattutto praticato come bene ed è male ciò che dai più è vissuto ed evitato come male; è questo lo strumento, la via, il metodo più rozzo e grossolano per identificare il bene e metterlo in pratica.
Il secondo è quello di rifarsi a qualcuna delle maggiori tradizioni spirituali che si sono affermate nella storia o addirittura ad una qualche sintesi di esse, ad una specie di religione o di filosofia sincretiche.
Questo strumento è sicuramente più elevato del primo, è un metodo più raffinato, in quanto non si accontenta di conformarsi al gregge, ma si rifà a modelli di comportamento che spesso sono in contrasto col senso comune e prevalente.
Il terzo modo è quello di chi, pur tenendo conto della società che ci circonda e dei suoi modelli culturali, pur tenendo conto degli insegnamenti che ci vengono dalle maggiori tradizioni spirituali che si sono affermate nel corso della storia, si affida in prima e ultima istanza alla voce tutta interiore della propria coscienza, la quale può arrivare a mettere in discussione non solo le convenzioni sociali, ma perfino le più accreditate e nobili tradizioni spirituali.
E’ quello che fa, appunto, il samaritano della parabola evangelica, il quale non si comporta né in base al costume della propria tribù (che avrebbe dovuto fargli sentire estraneo l’uomo caduto nelle mani dei briganti), né gli insegnamenti dei sacerdoti della propria religione (che avrebbero dovuto sconsigliargli di soccorrere un uomo di un’altra corrente religiosa), ma ascolta unicamente la voce della propria coscienza che gli intima di vedere nell’uomo derubato e percosso a sangue un suo simile e perciò un suo fratello, un essere umano a cui prestare soccorso, senza fare tante distinzioni di etnie o di credi religiosi.
A questo punto mi resta da dare una risposta (sintetica)ad un’ultima domanda: cosa dice “la storia del samaritano e dei viandanti indifferenti” ad un uomo come me, ad un uomo che non si riconosce (più) nella fede in un Dio trascendente e, meno che mai, in Gesù come figlio di Dio e quindi Dio lui stesso?
Dice molto. E la risposta mi viene suggerita ancora una volta da Matteo 25,31-40, laddove Gesù parla di se stesso non come “figlio di Dio”, ma come “il Figlio dell’uomo”.
Ecco, per me laico, uomo di mondo, di questo mondo, che non crede nell’esistenza di un altro mondo, ma che, per una sorta di grazia ricevuta, non divina ma comunque grazia, è ben contento di stare in questo mondo, di godere della vita (l’unica vita) che gli è stata data, l’amore è ciò che dà senso e sapore alla sua esistenza.
E non perché egli veda nell’Altro il volto di Dio e, meno che mai, perché alla fine dei tempi sarà giudicato su quanto avrà amato il suo prossimo.
Ma perché nell’Altro io vedo “il Figlio dell’uomo” e, quindi, vedo me stesso; l’Altro non è davvero altro da me, ma è il prolungamento di me stesso; e, se quindi voglio fare del bene a me stesso, se davvero mi voglio bene, se davvero mi amo, non posso fare a meno di fare del bene anche all’altro, di volere bene anche all’altro, di amare l’altro.
L’amore, quindi, per me non è un comandamento (“Ama il prossimo tuo come te stesso!”), ma è un’esigenza profonda, quasi spontanea, dello spirito (“Ama te stesso anche attraverso il prossimo tuo”), in quanto il prossimo tuo è parte di te e, quindi, non puoi amare davvero te stesso, se non ami pure l’altro.
Il disamore dell’altro, del prossimo, è figlio della disperazione, della divisione interiore, incapace di cogliere che noi siamo parte di un tutto, non individui isolati l’un contro gli altri armati, ma soggetti sodali, solidali, corpo unico.
Per i quali vale la regola d’oro, non a caso trasversale a tutte le più grandi tradizioni spirituali: “Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te stesso”, ma, anzi, “Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te stesso”.
Quindi l’amore non come comandamento, ma come interesse, come convenienza dello spirito. Che ha del resto riscontri e conferme persino nella psicologia, come ognuno di noi ha modo di verificare nella sua esperienza.
Quando amiamo, infatti, quando ci apriamo all’altro, il nostro cuore si allarga ed è felice (l’unica vera e profonda felicità che ci è dato di sperimentare).
Quando disamiamo, quando ci chiudiamo all’altro, quando non vediamo l’altro (specie nel momento in cui l’altro soffre ed ha bisogno del nostro aiuto, materiale o, a volte, anche solo morale), quando, come dice il Papa, ci giriamo dall’altra parte e facciamo finta di non vedere l’altro, allora il nostro cuore si chiude, si contrae e diventa fatalmente triste, pesante, malinconico, anche se siamo circondati di beni materiali e di mille comfort.
Nessuna ricchezza vale la ricchezza dell’amore, di quello dato, ancora più che di quello ricevuto.
Giovanni Lamagna










 LA COMUNITA’ SI INCONTRA A MIANELLA
LA COMUNITA’ SI INCONTRA A MIANELLA INCONTRI GENERALI 2024 – 2025
INCONTRI GENERALI 2024 – 2025










 Ho conosciuto Nicola in alcune riunioni della nuova sinistra napoletana, presente, attivo e sempre molto analitico nei suoi interventi. L’ho conosciuto meglio quando si è avvicinato alla nostra Comunità seguendoci nelle discussioni e nelle iniziative, forse incuriosito anche da questa esperienza singolare di una spiritualità laica. Nicola è stato sicuramente un compagno di vasta cultura e,spesso, lo evidenziavano i suoi lunghissimi, chilometrici commenti sui social (con soventi nostre insofferenze) che spaziavano dalla politica all’arte, dalla storia allo sport, al costume, sempre con competenza e personale partecipazione. A me Nicola è sembrato spesso una persona di altri tempi, in senso positivo, rispetto al cinismo, disumanita’, carrierismo che caratterizza questo nostro tempo. Lui, invece, con la sua gentilezza, generosità, il lavoro di avvocatura al servizio degli ultimi, un aspetto quasi di innocenza fanciullesca. L’impegno per la causa del popolo sahavariano lo ha visto lavorare fino agli ultimi giorni di vita. Adesso, caro Nicola, continueremo ad ascoltarti, stavolta nell’essenza del silenzio, e forse apprezzerete di più la tua voglia di comunicare. Riposa in pace!
Ho conosciuto Nicola in alcune riunioni della nuova sinistra napoletana, presente, attivo e sempre molto analitico nei suoi interventi. L’ho conosciuto meglio quando si è avvicinato alla nostra Comunità seguendoci nelle discussioni e nelle iniziative, forse incuriosito anche da questa esperienza singolare di una spiritualità laica. Nicola è stato sicuramente un compagno di vasta cultura e,spesso, lo evidenziavano i suoi lunghissimi, chilometrici commenti sui social (con soventi nostre insofferenze) che spaziavano dalla politica all’arte, dalla storia allo sport, al costume, sempre con competenza e personale partecipazione. A me Nicola è sembrato spesso una persona di altri tempi, in senso positivo, rispetto al cinismo, disumanita’, carrierismo che caratterizza questo nostro tempo. Lui, invece, con la sua gentilezza, generosità, il lavoro di avvocatura al servizio degli ultimi, un aspetto quasi di innocenza fanciullesca. L’impegno per la causa del popolo sahavariano lo ha visto lavorare fino agli ultimi giorni di vita. Adesso, caro Nicola, continueremo ad ascoltarti, stavolta nell’essenza del silenzio, e forse apprezzerete di più la tua voglia di comunicare. Riposa in pace!

































































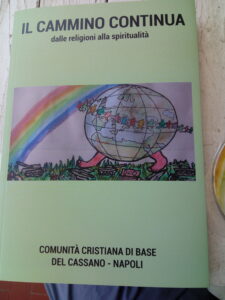


















































































 “Il Signore promette ristoro e liberazione a tutti gli oppressi del mondo, ma ha bisogno di noi per rendere efficace la sua promessa. Ha bisogno dei nostri occhi per vedere le necessità dei fratelli e delle sorelle – Ha bisogno delle nostre mani per soccorrere. Ha bisogno della nostra voce per denunciare le ingiustizie commesse nel silenzio, talvolta complice, di molti“.Andate a imparare che cosa vuol dire: ‘Misericordia io voglio e non sacrifici’ (9,13). È un’accusa diretta verso l’ipocrisia sterile di chi non vuole “sporcarsi le mani”, come il sacerdote e il levita della parabola del Buon Samaritano. Si tratta di una tentazione ben presente anche ai nostri giorni, che si traduce in una chiusura nei confronti di quanti hanno diritto, come noi, alla sicurezza e a una condizione di vita dignitosa, e che costruisce muri, reali o immaginari, invece di ponti”.
“Il Signore promette ristoro e liberazione a tutti gli oppressi del mondo, ma ha bisogno di noi per rendere efficace la sua promessa. Ha bisogno dei nostri occhi per vedere le necessità dei fratelli e delle sorelle – Ha bisogno delle nostre mani per soccorrere. Ha bisogno della nostra voce per denunciare le ingiustizie commesse nel silenzio, talvolta complice, di molti“.Andate a imparare che cosa vuol dire: ‘Misericordia io voglio e non sacrifici’ (9,13). È un’accusa diretta verso l’ipocrisia sterile di chi non vuole “sporcarsi le mani”, come il sacerdote e il levita della parabola del Buon Samaritano. Si tratta di una tentazione ben presente anche ai nostri giorni, che si traduce in una chiusura nei confronti di quanti hanno diritto, come noi, alla sicurezza e a una condizione di vita dignitosa, e che costruisce muri, reali o immaginari, invece di ponti”.

























 SABATO 24 FEBBRAIO 2024
SABATO 24 FEBBRAIO 2024



























 accogliere gli altri profughi che arrivano a noi scappando da altre guerre, fame e lager di tortura. Questa crisi sta mettendo in luce come questa Europa non è capace di progettare il suo ruolo geo-politico in un mondo dove tutti siamo sulla stessa barca.
accogliere gli altri profughi che arrivano a noi scappando da altre guerre, fame e lager di tortura. Questa crisi sta mettendo in luce come questa Europa non è capace di progettare il suo ruolo geo-politico in un mondo dove tutti siamo sulla stessa barca.





 di Domenico Pizzuti
di Domenico Pizzuti

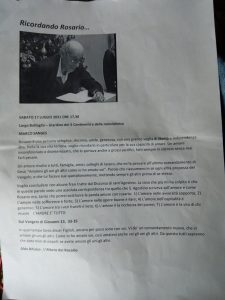





















 “…E qui rinnovo il mio appello affinché «in considerazione delle circostanze […] si mettano in condizione tutti gli Stati, di fare fronte alle maggiori necessità del momento, riducendo, se non addirittura condonando, il debito che grava sui bilanci di quelli più poveri»[6]”.“…«Una nuova etica presuppone l’essere consapevoli della necessità che tutti s’impegnino a lavorare insieme per chiudere i rifugi fiscali, evitare le evasioni e il riciclaggio di denaro che derubano la società, come anche per dire alle nazioni l’importanza di difendere la giustizia e il bene comune al di sopra degli interessi delle imprese e delle multinazionali più potenti»[9]. Questo è il tempo propizio per rinnovare l’architettura finanziaria internazionale[10].”
“…E qui rinnovo il mio appello affinché «in considerazione delle circostanze […] si mettano in condizione tutti gli Stati, di fare fronte alle maggiori necessità del momento, riducendo, se non addirittura condonando, il debito che grava sui bilanci di quelli più poveri»[6]”.“…«Una nuova etica presuppone l’essere consapevoli della necessità che tutti s’impegnino a lavorare insieme per chiudere i rifugi fiscali, evitare le evasioni e il riciclaggio di denaro che derubano la società, come anche per dire alle nazioni l’importanza di difendere la giustizia e il bene comune al di sopra degli interessi delle imprese e delle multinazionali più potenti»[9]. Questo è il tempo propizio per rinnovare l’architettura finanziaria internazionale[10].” «che può essere l’occasione per una transizione positiva, ma che richiede grandi cambiamenti: nel mondo del lavoro, nell’economia, nella nostra stessa organizzazione sociale, nel nostro equilibrio con la natura. Il Papa ha chiesto a noi economisti delle proposte concrete per affrontare queste sfide, che abbiano basi solide ma anche la creatività del Vangelo». La direzione verso cui la commissione post Covid-19 del Vaticano sta lavorando è quella di un modello economico più sostenibile e dell’ecologia integrale, per questo suor Alessandra è coinvolta anche nell’anno di celebrazioni della Laudato si’, l’enciclica sulla custodia del creato di papa Francesco, a cinque anni dalla pubblicazione il 24 maggio 2015. «Questi cinque anni sono stati il periodo della ruminatio», afferma suor Smerilli. «La Laudato si’ è stata accolta subito con entusiasmo, anche in ambienti non cattolici. Sono partite iniziative in tutto il mondo: penso alle famiglie che si sono unite per ridurre i consumi, alle nuove “comunità Laudato si’”, alle università e alle parrocchie che stanno attuando la conversione ecologica e danno spazio a una spiritualità del creato, all’interessante fenomeno dei monasteri a impatto zero, a tante persone non credenti che si sono mosse ispirate dall’enciclica. All’inizio si è trattato di iniziative sporadiche, che poi però sono state messe a sistema da chi, profondamente convinto, si è fatto promotore del cambiamento. L’anno di celebrazione sarà un altro inizio, cui seguiranno sette anni – un numero biblico, non a caso, per far crescere queste pratiche di transizione ecologica e replicarle, fare massa critica e aumentare l’impatto sulla politica e su chi deve prendere decisioni».
«che può essere l’occasione per una transizione positiva, ma che richiede grandi cambiamenti: nel mondo del lavoro, nell’economia, nella nostra stessa organizzazione sociale, nel nostro equilibrio con la natura. Il Papa ha chiesto a noi economisti delle proposte concrete per affrontare queste sfide, che abbiano basi solide ma anche la creatività del Vangelo». La direzione verso cui la commissione post Covid-19 del Vaticano sta lavorando è quella di un modello economico più sostenibile e dell’ecologia integrale, per questo suor Alessandra è coinvolta anche nell’anno di celebrazioni della Laudato si’, l’enciclica sulla custodia del creato di papa Francesco, a cinque anni dalla pubblicazione il 24 maggio 2015. «Questi cinque anni sono stati il periodo della ruminatio», afferma suor Smerilli. «La Laudato si’ è stata accolta subito con entusiasmo, anche in ambienti non cattolici. Sono partite iniziative in tutto il mondo: penso alle famiglie che si sono unite per ridurre i consumi, alle nuove “comunità Laudato si’”, alle università e alle parrocchie che stanno attuando la conversione ecologica e danno spazio a una spiritualità del creato, all’interessante fenomeno dei monasteri a impatto zero, a tante persone non credenti che si sono mosse ispirate dall’enciclica. All’inizio si è trattato di iniziative sporadiche, che poi però sono state messe a sistema da chi, profondamente convinto, si è fatto promotore del cambiamento. L’anno di celebrazione sarà un altro inizio, cui seguiranno sette anni – un numero biblico, non a caso, per far crescere queste pratiche di transizione ecologica e replicarle, fare massa critica e aumentare l’impatto sulla politica e su chi deve prendere decisioni».





Commenti recenti